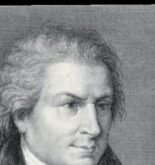In chiusura al ciclo di incontri intitolato La storiografia tra microstoria e storia intellettuale globale, promosso dal dottorato di ricerca in Studi storici del Dipartimento di Studi Storici Federico Chabod dell’Università degli Studi di Milano, in data 4 dicembre 2024 si è tenuto un incontro che ha visto protagonista Carlo Ginzburg.
Professore emerito alla UCLA, dov’è stato titolare della cattedra di Italian Renaissance studies dal 1988 al 2006, e professore emerito alla Scuola Normale Superiore, dove ha insegnato Storia delle culture europee dal 2006 al 2010, Carlo Ginzburg ha ricevuto 19 lauree honoris causa e numerosi premi, tra i quali l’Aby Warburg Prize (1992), il premio Feltrinelli (2005) e il Balzan Prize (2010). Nel 1986 è stato eletto International Honorary Member dell’American Academy of Art and Sciences, nel 2008 membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei e nel 2013 International Member of the American Philosophical Society. Tra i numerosi saggi pubblicati, tradotti in più di 20 lingue, si ricordano in questa sede il primo e l’ultimo: I benandanti, stregoneria e culti agrari tra 500 e 600 (Einaudi, 1966) e La lettera uccide (Adelphi, 2021).
Intitolato Storicismo, microstoria e global history: conversazione con Carlo Ginzburg, l’incontro si è svolto proprio nella modalità di una conversazione tra Carlo Ginzburg, Davide Cadeddu e gli studenti del Dottorato di ricerca in Studi storici e del Corso di laurea magistrale in Scienze Storiche, nell’ambito dell’insegnamento Elementi di Storiografia.
La conferenza si è avviata a partire da alcune considerazioni generali esposte da Cadeddu. In particolare, il primo tema toccato è stato quello del rapporto tra Ginzburg e Arnaldo Momigliano, figura intellettuale che ha avuto rilevante influsso sull’evoluzione del pensiero di Ginzburg e al quale sono dedicati Rapporti di forza: storia, retorica, prova, il saggio Descrizione e citazione contenuto in Il filo e le tracce: vero, falso, finto e una riflessione nel saggio A Momigliano e Demartino, pubblicato sulla «Rivista Storica Italiana» proprio all’indomani della morte di Momigliano. Più volte indicato da Ginzburg come “il più grande storico del Novecento”, è stato domandato a Ginzburg se da Momigliano, oltre all’attenzione alla storia antiquaria, non possa provenire in modo indiretto anche la marcata sensibilità verso temi quali l’interesse individuale dello storico, l’attenzione al tema del contesto storico e la rilevanza del rapporto tra particolare e universale, tipici dello storicismo assoluto di Benedetto Croce. Dalla conversazione è emerso quanto Ginzburg intenda discostarsi dall’approccio storiografico crociano.
Ginzburg introduce il suo rapporto con lo storicismo e in particolare con Croce a partire da una nota autobiografica, ricordando il rapporto intellettuale tra Leone Ginzburg, suo padre, e Croce. Cresciuto a stretto contatto con le opere di Croce, Ginzburg rivela tuttavia di essersi trovato molto più affascinato dal Croce filosofo, percependo invece come più distante lo storicismo assoluto crociano. Premessa la difficoltà nel discutere di storicismo, tema di per sé sfuggente, Ginzburg ha successivamente chiarito come egli stesso si sia in realtà astenuto dall’utilizzare il termine “storicismo” se non in quella da lui definita prospettiva emic. Tale prospettiva emic richiama la dicotomia etic/emic proposta per la prima volta da Kenneth Pike, linguista e filosofo protestante; dicotomia ampiamente discussa da Ginzburg nel saggio Le nostre parole e le loro, nel quale essa viene rielaborata. Dalla riflessione emerge una conclusione in netto contrasto con quanto precedentemente affermato da Croce, in effetti bersaglio invisibile della rielaborazione di Ginzburg: secondo quest’ultimo, infatti, gli storici partono da categorie etic che sono fondamentalmente anacronistiche, ma che possono essere successivamente corrette attraverso l’esame della documentazione, esame che permette di afferrare il contesto e gli attori osservati in una prospettiva emic. Secondo Ginzburg, dunque, nell’affermare che “ogni storia è storia contemporanea”, Croce sottovaluta il rischio dell’anacronismo. Ginzburg ha invece tentato di riformulare la presenza dello storico nella ricerca, questo proprio riprendendo Pike, e partendo dunque da un approccio alla ricerca che si muova in senso retrospettivo: secondo Ginzburg la riflessione metodologica è infatti sempre retrospettiva e deve essere alimentata da una ricerca empirica, non precederla.
Successivamente, Davide Cadeddu ha posto l’attenzione sull’influenza dell’opera di R.G. Collingwood su Ginzburg – in particolare per quanto riguarda la netta distinzione tra passato e presente operata dall’autore britannico nelle sue ultime opere, nelle quali più si allontana da Croce –e in relazione all’opera Microstoria, due o tre cose che so di lei. Nell’opinione di Ginzburg, “la presentificazione implica sempre un’esperienza limitata e parziale, basata su dialogo tra due contesti, quello dell’osservatore e quelli degli attori […] in altre parole, ogni vera storia è storia comparata”. È stato domandato al professor Ginzburg di approfondire questa sua affermazione, soprattutto in relazione al fatto che – se la comparazione è inevitabile quando si fa ricerca storica – essa riduce in qualche modo la possibilità di comprendere i singoli fenomeni nella loro autonomia. Dalla conversazione, è emerso come secondo Ginzburg non esistano eventi o fenomeni che, se soggetti ad analisi comparativa, possano veder attenuata o distrutta la loro unicità.
È successivamente stata menzionata la figura di Hayden White, professore emerito alla UCLA, teorico della svolta linguistica in storia, noto soprattutto per la sua riflessione su concetti come narrazione e retorica. È noto il dibattito che contrappose White e Ginzburg tra anni Settanta e primi anni Duemila, legato soprattutto ai temi della verità storica e del verosimile. Per White il verosimile storiografico è un effetto di realtà prodotto da determinati stratagemmi narrativi, egli lega la verità all’efficacia della narrazione. Secondo Ginzburg, il verosimile è un criterio di ricostruzione congetturale a partire da fatti certi, testimoniati dal contenuto delle fonti: in Ginzburg, la rappresentazione storica segue un principio di realtà che permette di distinguere narrazione storica e invenzione romanzesca. Ginzburg definisce nietzschiana la concezione della retorica di White, contrapposta a una concezione di retorica aristotelica che ruota attorno al concetto di prova. Tuttavia, nonostante le numerose e rilevanti divergenze intellettuali, Ginzburg condivide con White la contrapposizione tra storia e memoria, sebbene le motivazioni alla base di tale contrapposizione siano differenti. In questo senso, è stato domandato dal professor Cadeddu quanto memoria e storiografia siano da considerare contrapposte e quanto possano invece essere complementari.
Anche White viene presentato da Ginzburg a partire da un episodio autobiografico, nello specifico relativo a una conferenza tenutasi nel 1990 alla UCLA, durante la quale Ginzburg attaccò duramente White dopo che questi aveva esposto le sue peculiari convinzioni circa l’impossibilità di giungere a una differenziazione rigorosa tra narrazioni di finzione e narrazioni storiografiche. Dall’episodio nacque l’idea di un convegno, nel corso del quale Ginzburg presentò un saggio intitolato Unus testis, just one witness, allo scopo di giungere a una posizione che potesse far fronte alla svolta neo-scettica introdotta in ambito storiografico da intellettuali come White. Tuttavia, nei successivi mesi di insegnamento, Ginzburg si rese conto di come simili posizioni suscitassero diffusa fascinazione, nonostante fossero caratterizzate da una tangibile negligenza rispetto ai fatti documentati – negligenza che portava con sé conseguenze politiche e morali estremamente rilevanti. Proprio su questa spinta Ginzburg decise di dedicarsi a una sorta di confutazione impegnata di simili tesi, non più in diretta polemica con White ma con la corrente neo-scettica in generale. È in questo ambito che emerge il problema della prova, nozione della quale Ginzburg si fa in qualche modo il difensore. Secondo Ginzburg la nozione di prova rinvia, come già accennato, a due tradizioni retoriche distinte: quella di Aristotele, Quintiliano e Valla, in cui la prova è elemento fondamentale, e quella nietzschiana e anti-aristotelica, nella quale la prova viene respinta. La retorica di White si collocava sulla stessa linea retorica di Nietzsche, ignorando la tradizione aristotelica.
Per quanto riguarda il rapporto storia-memoria, Ginzburg chiarisce come si tratti di due elementi distinti. La memoria è un elemento autentico, ma non costituisce necessariamente una prova. In questo senso storia e memoria sono distinte: la memoria può essere analizzata storicamente, la storia se ne nutre, ma sono due mondi separati.
Sono stati infine toccati i temi della microstoria e del rapporto tra micro e macro. Nell’introdurre il discorso, Ginzburg si è servito di una metafora particolarmente efficace: facendo riferimento ai vetrini del microscopio, egli ha spiegato come la particella “micro” nel termine microstoria non si riferisca alla concreta dimensione della ricerca ma faccia riferimento proprio allo strumento scientifico. Utile mezzo esemplificativo, il riferimento al microscopio ha aperto un discorso che presto ha coinvolto le scienze dure e la modalità d’indagine loro propria. Richiamandosi al procedimento sperimentale proprio della ricerca scientifica in senso stretto, Ginzburg ha proposto infatti il concetto di “esperimento mentale” quale elemento costitutivo della ricerca storica. Secondo Ginzburg, parte integrante della ricerca storica è costituita da un ragionamento fondato su elementi non congetturali ma documentari: questo ragionamento, questa catena, si innesta per Ginzburg sull’esperimento mentale. Tale procedimento richiama il reenactment di Collingwood. In sintesi, Ginzburg spiega come l’esperimento mentale sia insito nella molteplicità di traiettorie che vengono seguite nel momento in cui si interroga un documento per comprendere ciò che concretamente esso contiene – l’esperimento mentale è l’insieme delle traiettorie di volta in volta tentate per arrivare alla “verità del documento”. Ed è proprio nell’esperimento mentale che per Ginzburg sta la prova, l’elemento che rende la narrazione storica diversa da altri tipi di narrazione. Anche la comparazione cui si è accennato in precedenza, alla luce di queste ultime riflessioni, non costituisce soltanto una semplice ricerca di convergenze: si tratta di un esperimento mentale, non di una semplice identificazione, attraverso la quale viene portata avanti la ricerca storica.
L’incontro si è concluso con alcune domande del pubblico, tramite le quali sono stati ulteriormente approfonditi temi quali la comparazione, il ruolo del neo-scetticismo nella storiografia contemporanea, quello dell’antropologia e della ricerca etnografica, e il rapporto di Ginzburg con autori come Bloch, Croce e Momigliano.
Emma Schiocchet