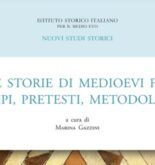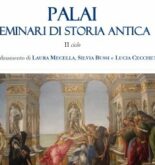Il 25 febbraio 2025 presso la Civica Raccolta delle stampe A. Bertarelli si è svolto il secondo seminario del ciclo “Emersioni di carta”, organizzato da Ilaria Ampollini ed Elisa Marazzi, docenti rispettivamente del Dipartimento di Filosofia Piero Martinetti e del Dipartimento di Studi storici Federico Chabod dell’Università degli Studi di Milano. Introduce l’incontro Francesca Tasso, direttrice dei musei del Castello Sforzesco, che nel suo breve intervento, prima di presentare le relatrici, sottolinea l’importanza che la Raccolta “Bertarelli” ha continuato ad avere nei suoi quasi cento anni di attività, per la ricostruzione dell’immaginario visivo degli ultimi secoli.
La prima a prendere la parola è Elisabetta Modena, attualmente docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università IULM, con un intervento intitolato “Storie che affiorano. Dal libro pop-up alla realtà aumentata”. Viene premesso che non si tratta di una ricerca volta a rintracciare uno sviluppo organico che dai libri pop-up ha portato inevitabilmente alle tecnologie digitali odierne, ma di uno studio che si propone semplicemente di raccontare elementi “emersivi” ed “immersivi” riscontrati anche in epoca predigitale.
L’elemento di immersione presente nella realtà virtuale, definita ultimate display da Ivan Sutherland, suo inventore, e che, sempre secondo Sutherland, «Con una programmazione appropriata, […] potrebbe letteralmente essere il Paese delle Meraviglie dentro il quale Alice entrò», si ritrova infatti nel “panorama”, una struttura simile al tendone di un circo, ideata a fine Settecento. All’interno, lo spettatore, posto al centro, era circondato da immagini dipinte sulle pareti, ritrovandosi immerso in una realtà artificialmente costruita. Grazie alla sua capacità di trasferire la percezione dell’individuo dal mondo dell’immaginario, proprio ad esempio della lettura, a quello della sfera sensoriale, il panorama diventa ben presto una vera e propria moda; quelle strutture, che inizialmente rappresentavano paesaggi, diventano dunque mezzi per raccontare storie, spesso con valore celebrativo, come nel caso del panorama della battaglia di Sedan ad opera di Anton von Werner, inaugurato nel 1883 e rievocativo della cruciale vittoria prussiana ai danni della Francia di Napoleone III.
Durante l’Ottocento ad avere grande successo sono anche i “libri panorama”, libri pop-up vicini all’idea del gioco e rivolti ad un pubblico di bambini, dotati di una struttura a fisarmonica che, tramite il susseguirsi orizzontale dei pannelli di carta, creavano la propria storia, o trasmettevano contenuti non narrativi come l’alfabeto o la genealogia della famiglia regnante. Con la maggiore diffusione dei libri pop-up, non solo il lettore è immerso nella storia, ma sono le immagini stesse a emergere dal testo assumendo una dimensione propria. È il caso del Livre jou-jou, citato da Walter Benjamin come perfetto esempio di interazione tra lettore e libro; la storia tratta di un principe persiano le cui peripezie terminano, in perfetto stile fiabesco, con alcuni eventi lieti, i quali appaiono sulla carta solo tramite l’azione del lettore, che li scopre tirando una linguetta. La storia non prende piede unicamente tramite la fantasia del bambino ma anche meccanicamente grazie alla sua azione, esaudendo allo stesso tempo il sogno proprio di ogni lettore di far parte della storia. Come riporta Hannah Field in Playing with the Book, studio che ricostruisce la storia di libri di questo tipo in epoca Vittoriana, la proattività del lettore nella storia valorizza la dimensione fisica della lettura.
Tornando al collegamento tra una certa interattività predigitale e i giorni nostri, è il MagicBook a fornire uno spunto di riflessione, per di più riferendosi esplicitamente ai libri pop-up. Tecnologia alla base degli augmented reality picture books, mescola realtà aumentata e virtuale, l’una emersiva l’altra immersiva: tramite un visore il lettore può vedere la pagina emergere verso di sé o, mediante un avatar, immergersi nelle pagine del libro ed entrare nel Paese delle Meraviglie citato da Sutherland.
Dedicata all’universo di Carrol è l’esperienza virtuale ideata dall’illustratrice islandese Kristjana Williams presso il Victoria & Albert Museum di Londra, che permette allo spettatore, tramite apposite tecnologie, di immergersi nel mondo di Alice. La Williams, interrogata sul suo processo creativo, affermerà di essersi ispirata anche ai paper theaters, composizioni create a partire dal XIX secolo sovrapponendo strati di carta con un foro centrale, proponendo la visione di un pozzo di immagini, fornendo profondità e ricordando proprio la tana del Bianconiglio, sottolineando così un collegamento tra i secoli che mantiene costante, nonostante le diverse tecnologie, il rapporto di interazione sensoriale tra l’uomo e la realtà immaginaria che lo circonda.
Il secondo intervento del pomeriggio è proposto da Elisa Marazzi, docente di Storia del libro all’Università degli Studi di Milano, e intitolato “Fogli da ritagliare, fogli per giocare. Le stampe illustrate ‘emersive’”. Se Modena si era occupata di libri pop-up che fisicamente emergevano nelle tre dimensioni, Marazzi invece si concentra su stampe la cui “emersività” non era fisica, ma si realizzava attraverso l’interazione con l’osservatore.
Queste stampe sono state in passato definite “popolari”, termine che implica un giudizio di valore e una contrapposizione con una cultura più alta: non mancano però opere di quella stessa cultura ritenuta superiore che sono in qualche misura influenzate dalle immagini e dalle raffigurazioni in voga tra la popolazione meno istruita. Ne sono esempio il Barbablù di Doré e il Mangiafuoco di Mazzanti, entrambi con caratteristiche molto simili a quelle del Barbablù delle stampe popolari francesi. I materiali esaminati durante l’intervento possono essere divisi in tre categorie: quelli intesi per la sola osservazione, i tabelloni dei giochi da tavolo e le stampe create per essere ritagliate e manipolate.
Il primo modello analizzato è quello delle “grida di”, riferite alle professioni di strada che venivano raffigurate con una didascalia molto ridotta: il grido del venditore per attirare clienti illustrando la propria merce. A fruire di queste stampe era una popolazione semianalfabeta che frequentava quelle stesse figure rappresentate e che spesso fu in grado di migliorare le proprie abilità di lettura leggendo e rileggendo frasi che già ben conosceva. Le prime “grida” erano comparse già nel Seicento senza un chiaro pubblico di riferimento; così non fu durante l’Ottocento quando gli stampatori individuarono sempre più chiaramente i bambini come destinatari principali. Oltre all’intento didattico era l’esigenza economica a premere per una decisione di questo tipo; infatti, con una popolazione più alfabetizzata, gli adulti leggevano sempre più periodici e riviste, portando ad un calo di guadagni per gli stampatori di fogli illustrati. I bambini non si limitavano a osservare le stampe ma vi interagivano costantemente, ritagliandole e incollandole negli scrapbook o inventando qualche gioco da fare con esse. Gli stampatori potevano dunque, a questo punto, anche abbracciare l’intento ludico dei bambini e mandare in produzione fogli esplicitamente rivolti al gioco. Non per questo veniva meno un certo intento didattico o in alcuni casi addirittura propagandistico: emblematica la “lotteria per fanciulli” (1902-1905), mostrata dalla professoressa, dove è lo stemma d’Italia a vincere la partita.
Più organici delle stampe da gioco erano i tabelloni per giochi da tavolo, anch’essi con scopi educativi o propagandistici: dal Chronological Star of the World che ripercorre gli avvenimenti salienti dell’umanità lungo il percorso della partita, al “Giuoco dell’oca del vero Italiano”, stampato nel secondo Dopoguerra nel quale «Chi va al 30 (Marshall) va all’87 (abbondanza)». In questi casi, nonostante la loro bidimensionalità, questi documenti “emergono virtualmente” interagendo con la realtà circostante.
Il terzo modello di stampe analizzato, quello dei fogli intesi per essere ritagliati, non si discosta da questo intento didattico: Marazzi mostra a schermo delle tabelle di carte da ritagliare, che raffigurano le lettere dell’alfabeto con piccole didascalie moralizzanti, quella di O per Oca definisce il gioco di cui sopra «giuoco di nessun utile e nessun’abilità, tutto dipendente dal caso». Sempre di questa categoria fanno parte alcune stampe destinate a diventare davvero tridimensionali; la Tentation de Saint Antoine comprende una serie di figurine nere da ritagliare e proiettare su un muro tramite una luce retrostante, permettendo di inscenare la storia nella propria casa; naturalmente la necessità di distruggere questi fogli, ritagliandoli per usarli, rende difficile trovarne di ancora in buone condizioni. In alcuni casi il beneficio ottenuto da queste stampe era doppio: se da un lato le bambine si sarebbero divertite con ritagli cartacei di vestiti da mettere sulle bambole, dall’altro i vari marchi avrebbero potuto mostrare le nuove produzioni anche in luoghi lontani dalle singole boutiques. Per concludere il suo intervento Marazzi sottolinea come gioco e meraviglia, rivolti a un pubblico di bambini, fossero un modo per avvicinare larghe fasce di popolazione al materiale stampato, dando allo stesso tempo involontariamente agli storici un mezzo per indagare quelle vite che, frequentemente, non lasciano traccia nella documentazione “tradizionale”.
A terminare la giornata è l’intervento delle dottoresse Alessia Alberti e Francesca Mariano, conservatrici della Raccolta, che illustrano brevemente la figura di Achille Bertarelli (1863-1938) e dell’ente a lui intitolato. Proveniente da famiglia di imprenditori milanesi, Bertarelli sviluppa un peculiare interesse collezionistico per l’iconografia popolare e l’organizzazione delle sue stampe è ancora parzialmente presente nel catalogo della Raccolta. Alla fine dell’incontro c’è stata possibilità per il pubblico di vedere dal vivo alcune delle stampe delle quali si è parlato, in parte digitalizzate e accessibili mediante il catalogo online della “Bertarelli”.
Tommaso Ferrari