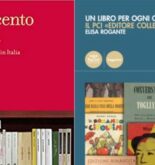Nell’ambito del corso di Storia Contemporanea del prof. Mauro Elli, si è tenuto venerdì 21 marzo, all’Università degli Studi di Milano, l’incontro con Andrea Avalli dal titolo “Costruzione di un’identità nazionale e razziale: il caso etrusco”. Il relatore si è soffermato sullo studio della storia delle discipline scientifiche e letterarie che hanno caratterizzato il rapporto degli italiani con l’antichità, mostrando come esso sia stato interpretato nel periodo a cavallo del fascismo, fra l’Italia liberale e la fase iniziale del periodo repubblicano. Su questi temi Avalli ha pubblicato il libro Il mito della prima Italia. L’uso politico degli Etruschi tra fascismo e dopoguerra (Viella, 2024), frutto delle ricerche compiute durante il dottorato in Storia contemporanea presso l’Università di Genova.
Da dove provengono gli etruschi? Già nell’antichità ci si interrogava sull’origine di questo misterioso popolo. Il primo ad affrontare il problema fu Erodoto, nel V sec a.C.: egli riteneva che fossero una popolazione orientale proveniente dall’Asia Minore, giunta nella penisola guidata dal mitico re Tirreno. Dopo qualche secolo, si fece strada la teoria di Dionigi di Alicarnasso (I sec a.C.) che invece riteneva fossero autoctoni della penisola italica, negando così qualsiasi legame con l’oriente. Anche nei secoli successivi non mancarono studiosi che si occuparono della questione ma una novità emerse e si diffuse a cavallo tra XVIII e XIX sec d.C. quando Nicolas Fréret e Barthold Georg Niebuhr, in tempi diversi, sostennero l’origine nordica degli etruschi.
È bene ricordare che nella prima metà del XX secolo, andava ancora per la maggiore l’antropologia fisica, ben diversa da quella culturale, che cercava di classificare le popolazioni antiche sulla base delle caratteristiche fisiche e biologiche, articolate nel concetto di razza. Considerato ciò, è interessante osservare come in Italia il dibattito si sia intrecciato all’annosa questione della costruzione dell’identità nazionale italiana, che portò molti studiosi a sostenere con forza l’autoctonia del popolo etrusco, indicato come parte integrante degli antenati italici.
Avalli, in particolar modo, si è focalizzato sul dibattito dell’origine e dell’identità degli etruschi nel periodo successivo al primo conflitto mondiale fino agli anni Settanta. Punto di partenza è la svolta nell’etruscologia contemporanea avvenuta nel maggio 1916 quando vennero ritrovate molte statue etrusche agli scavi di Veio e tra queste la famosa statua di Apollo, risalente al V sec a.C. La direzione dei lavori era stata affidata a Giulio Quirino Giglioli, uno dei più importanti archeologi italiani della prima metà del secolo scorso, che al tempo era dirigente politico della soprintendenza, nonché membro dall’Associazione Nazionalista Italiana. Sin da subito pubblicizzò la sua scoperta su giornali politici, riviste d’arte e di critica, esponendo le statue al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma ed invitando molti artisti importanti ad ammirarle.
Gli scavi archeologici così pubblicizzati diedero un grande impulso allo studio dell’arte etrusca facendo scoppiare una vera e propria moda culturale. Tra gli artisti contemporanei rimasti stregati dall’arte etrusca due sono i nomi di grande rilievo: gli scultori Arturo Martini e Marino Marini. Grazie a questi ritrovamenti, si vollero riscoprire le radici nazionali dell’arte italiana e si cominciò ben presto ad imitare l’arte etrusca. Nel ventennio fascista venne sfruttata la scultura italiana per diffondere la riscoperta dell’antichità italica, esaltando il sentimento di appartenenza alla nazione che si manifestava quindi con visite ai musei e riprendendo l’arte degli antichi. In questo modo il fascismo veicolò il razzismo non solo come paradigma politico, ma anche scientifico e artistico in grado di influenzare molti aspetti della vita quotidiana, andando – a livello culturale e della mentalità – a incoraggiare la condivisione di una idea di nazione fondata sulla razza.
Tuttavia, non solo in Italia gli etruschi vennero idealizzati come popolo antico e ben lontano dalla tradizionalità classica di greci e romani, ma anche in Inghilterra. Scrittori come David Herbert Lawrence e Aldous Huxley rimasero affascinati da questa antichità eccentrica e non-classica, che influenzò i loro romanzi. Certo non mancarono le critiche a questa visione da parte di George Orwell negli anni Quaranta perché, secondo lui, l’idealizzazione dell’antico portava alla fuga in un passato immaginario, ignorando i problemi contemporanei. In Francia lo scrittore antifascista Raymond Queneau, nel suo romanzo Le Chiendent (1933), creò una pungente satira dell’Italia fascista, rappresentandola come un regno etrusco in lotta contro la Francia.
L’identità etrusca venne rielaborata anche a fini identitari localisti, dagli esponenti di Strapaese. Si possono prendere come esempi i toscani Curzio Malaparte e Vincenzo Cardarelli, che sostennero una costruzione dell’identità nazionale a partire proprio dagli etruschi. Essi rivendicavano in questo modo la loro convinzione che il fascismo non potesse basarsi solo su Roma e il suo mito implicitamente rivendicando il ruolo dello squadrismo provinciale tipico degli albori del partito. La discussione al riguardo si accese a metà degli anni Venti, tuttavia dal punto di vista politico non ebbe conseguenze rilevanti a causa dell’accentramento decisionale voluto da Mussolini e così rimase solo una corrente sul piano artistico.
Il regime fascista, sia a livello toscano che nazionale, si appropriò dell’identità etrusca per insistere sull’antichità della nazione e della razza italiana. Gli studiosi che diedero vita all’etruscologia si misero a disposizione del regime, che promosse questo rapporto tra cultura e politica per veicolare la propria idea di Italia. Infatti, la prima cattedra di etruscologia nacque a Roma proprio negli anni Trenta grazie al clima politico favorevole. Inoltre, non va dimenticato che il regime mussoliniano fece del fascio etrusco prima il simbolo del partito e poi dell’intero Stato.
Quale fu il legame tra il razzismo italiano e l’origine degli etruschi? Negli ultimi anni del regime fascista (1938-43) si intensificò il dibattito razziale sulla loro provenienza, proprio in concomitanza con l’emanazione delle leggi razziali in Italia; questo comportò sempre maggiori ingerenze da parte della politica in campo culturale. In quel periodo ben tre classificazioni degli etruschi, legate alle priorità razzistiche del momento, si contendevano la scena: il razzismo biologico proposto da E. Fischer legato all’origine indoeuropea, le teorie di A. Rosenberg sull’origine orientale riprese principalmente da Julius Evola e infine il nazional-razzismo di Massimo Pallottino, sostenitore dell’autoctonia.
È interessante osservare come al termine della Seconda guerra mondiale Pallottino, che era stato un’intellettuale fascista militante, divenne l’etruscologo più noto e influente. Egli adattò il suo approccio alla situazione politica corrente, rinviando agli etruschi per la ricerca sulle origini dell’Occidente e dell’Europa. Dure critiche vennero mosse alle sue concezioni da parte di Ranuccio Bianchi Bandinelli, il quale riteneva che il mito degli etruschi, formatosi nel ventennio precedente, fosse un equivoco reazionario e irrazionalista.
Il discorso sugli etruschi negli anni Sessanta e Settanta influenzò gli ambiti cinematografico e letterario. Nel famoso film Il Sorpasso di Dino Risi (1962), nelle battute del protagonista interpretato da Vittorio Gassman, si palesa un vero e proprio rigetto degli etruschi, considerati ormai retaggio di un passato trascorso, che bisogna lasciarsi alle spalle per proiettarsi con slancio verso il futuro. Ancora, nel libro di Giorgio Bassani Il giardino dei Finzi-Contini, da cui venne tratto l’omonimo film diretto da Vittorio de Sica nel 1970, si cerca di svincolare gli etruschi da Roma, presentandoli come sconfitti e vittime di violenza.
Secondo Avalli, nell’etruscologia vi sarebbe dunque stata una sostanziale continuità tra periodo fascista e Italia repubblicana per quanto riguarda gli studiosi protagonisti, i quali non furono dei banali intellettuali prezzolati al servizio del regime. Essi hanno fornito nel tempo diverse interpretazioni dello stesso fenomeno adattandosi di volta in volta alle esigenze del presente e alle loro convinzioni. Avalli ha reso evidente, con pochi esempi, quale sia stato il ruolo della storia antica nei discorsi e nella rappresentazione dell’identità italiana nel corso del XX secolo.
Nicolò Gilardi