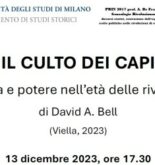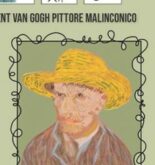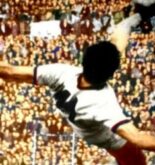Nel quadro del ciclo di incontri La storiografia tra microstoria e storia intellettuale globale, organizzato dal professor Davide Cadeddu presso l’Università degli Studi di Milano, mercoledì 6 novembre 2024 si è tenuto il terzo dibattito, intitolato Democrazie negate. Dalla Rivoluzione francese alla Resistenza italiana. In questa occasione, è stato ospite Ettore Rotelli, professore emerito dell’Università di Bologna e autore del libro Democrazie negate. Dalla Costituzione repubblicana della Rivoluzione francese alle istituzioni non costituenti della Resistenza italiana, pubblicato da Carocci.
Nel presentare l’ospite, Davide Cadeddu, dopo alcuni cenni biografici, ne ha illustrato sia l’esperienza politica sia le più importanti pubblicazioni accademiche. Il primo ambito è stato coronato da un mandato in Senato, durante il quale Rotelli ha contribuito alla scrittura dell’art. 114 della Costituzione, in qualità di autore della parte in cui viene sancito che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalla Regioni e dallo Stato», manifestazione politica di una ispirazione federalista coltivata attraverso anni di studio. Le pubblicazioni scientifiche, dal 1967 al 2018, evidenziano le profonde conoscenze storiche e giuridiche dell’ospite e mostrano un impegno intellettuale inizialmente dedicato al problema delle autonomie locali e a quello della formazione dello Stato moderno, che poi si è diretto verso il tema dei regimi democratici e delle forme di governo.
Il volume è costituito da una raccolta di saggi, composti tra il 2012 e il 2020 (e da un ultimo articolo inedito), che spaziano dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri. In essi, Rotelli presenta le proprie più recenti riflessioni intorno alla storia delle istituzioni politiche e al rapporto tra regimi democratici, forme di governo e forme di Stato. I saggi raccolti sono i seguenti: Condorcet 1793. La Costituzione più democratica della Rivoluzione, Il contenzioso amministrativo nel Regno d’Italia napoleonico, Milano e territori contermini: l’ordinamento amministrativo, Amministrare nella Destra: da sindaco di Imola a segretario generale dell’Interno, Rari nantes. Federalisti regionalisti e autonomisti, Resistenza non costituente; Centocinquant’anni senza autonomie, 150° senza unità.
Il titolo stesso del volume, Democrazie negate, indica come l’oggetto della riflessione sia il regime democratico, nella duplice forma rappresentativa e diretta. Nel prendere la parola, Ettore Rotelli dichiara che la raccolta di saggi vuole essere una riflessione che, a partire dalla Rivoluzione francese, giunge ai più stringenti temi di attualità. Fin da subito il relatore spiega la sua volontà di lasciare il massimo spazio possibile a contributi e interventi del pubblico, valorizzando così i diversi punti di vista, e per questa ragione decide di limitarsi a una introduzione di quei saggi a cui fa riferimento nel sottotitolo del volume.
L’esperienza della Rivoluzione francese genera una democrazia negata, perché la Costituzione che ne scaturisce non è quella veramente democratica che Condorcet aveva ipotizzato con il suo progetto, presentato nel febbraio del 1793 e caratterizzato dall’istituto del referendum popolare, da un sistema elettorale volto a dare dignità sia al voto di Parigi sia a quello degli altri ottantaquattro dipartimenti, e da un consiglio esecutivo composto da un numero limitato di ministri, invece che da un vertice monocratico.
La Costituzione di Condorcet prevede l’inserimento della democrazia diretta nel continuum di quella rappresentativa. Nel successivo testo costituzionale, promulgato dopo l’esclusione dei girondini dalla Convenzione, manca un istituto che permetta il controllo da parte del popolo sugli atti della rappresentanza nazionale, in un quadro complessivo che esprime un modello di Stato accentrato.
Il concetto di ‘democrazia negata’ si ripresenta nelle istituzioni non costituenti della Resistenza italiana. Il 30 novembre 1944, il Partito d’azione d’alta Italia rivolge un appello agli altri quattro partiti componenti il CLNAI, riguardo all’organizzazione dei territori liberati, le Repubbliche partigiane, amministrate dalle istituzioni resistenziali. Con questo appello, il cui primo ispiratore fu Altiero Spinelli, il Partito d’azione d’alta Italia propone, tramite il suo segretario Leo Valiani, che l’Italia liberata sia costituita partendo dal modello delle Repubbliche partigiane, realtà distinte dalle zone liberate e immediatamente riconsegnate alla monarchia. Attribuire legittimità costituente alle Repubbliche partigiane significherebbe evitare di reintrodurre i modelli di amministrazione centralizzata ben rappresentati dalla figura del prefetto, la cui presenza ostacola la democrazia. Fra i sostenitori di questa proposta vi è anche il futuro presidente della Repubblica Luigi Einaudi, che, mentre si trova in esilio in Svizzera, è autore dell’articolo Via il prefetto!, pubblicato il 17 luglio 1944 sulle colonne di «L’Italia e il Secondo Risorgimento», dove sostiene che «democrazia e prefetto repugnano profondamente l’una all’altro… non si avrà mai democrazia, finché esisterà il tipo di governo accentrato, del quale è simbolo il prefetto. Coloro i quali parlano di democrazia… e non si accorgono del prefetto, non sanno quel che dicono… Via il prefetto!».
Nonostante un simile modello si fosse concretamente realizzato nei giorni della liberazione di Firenze e del governo provvisorio del Comitato di liberazione regionale toscano, dal 2 al 16 agosto del 1944, gli altri quattro partiti del CLNAI rifiutano questa proposta. La Resistenza, pertanto, non è stata costituente nel momento in cui non è stata in grado di creare nuove istituzioni politiche prive del ruolo del prefetto, che seguita a esistere fino ai giorni nostri.
Altiero Spinelli, azionista e autore del Manifesto di Ventotene, prova a convincere il CLNAI, ma gli altri partiti rimangono fermi nel non voler mutare la natura dell’ordinamento, lasciando quindi che sussista continuità tra la nascente Repubblica e la precedente organizzazione amministrativa dell’Italia unita.
A questa introduzione di Rotelli, segue un proficuo momento di dialogo fra lui e l’uditorio. Numerose domande e contributi vari permettono di toccare le tante tematiche presenti nei diversi saggi.
Particolarmente vivace, la discussione permette importanti approfondimenti sul significato del prefetto nella storia dello Stato italiano fino a oggi. L’istituzione prefettizia, derivante dalla figura francese settecentesca degli intendenti, giunge in Italia con le armate napoleoniche e qui rimane come strumento di governo del territorio. Già nei primi anni del Regno, durante i governi della Destra storica, le prefetture svolgono un ruolo centrale, tanto nel garantire la sicurezza pubblica, quando nell’esercitare potere di nomina dei sindaci e nel controllare le attività dei consigli comunali.
Emblematica di questa fase è la figura di Giovanni Codronchi Argeli, prima sindaco di Imola di nomina prefettizia e poi, divenuto deputato, segretario generale del Ministero dell’Interno, figura apicale nell’amministrazione ministeriale, con il compito, fra gli altri, di destinare i prefetti nelle varie sedi. Da entrambe le posizioni Codronchi Argeli considera, e apprezza, la figura del prefetto come strumento dello Stato centrale per garantire sicurezza e controllo territoriale attraverso attività repressive da esercitarsi indifferentemente verso delinquenti comuni, esponenti repubblicani eversivi o meno, e anche come risposta al complesso fenomeno del malcontento siciliano.
Il regime fascista – ribadisce Rotelli – non ha inventato lo strumento prefettizio, bensì ha mantenuto e rafforzato il prefetto, perché, attraverso di esso, il capo del governo si può opporre ai ras, cioè agli esponenti periferici del regime fascista stesso, nel contesto di una lotta politica, tutta interna al Partito nazionale fascista, estremamente aspra.
In definitiva, sintetizza il relatore, la presenza dei prefetti è una costante nella Storia d’Italia, che viene intaccata solo una volta nel 1945 in Valle d’Aosta, dove è introdotto un modello di autonomia che non prevede il prefetto. Questa eccezione è tuttora esistente.
Il confronto e il dibattito si orientano, quindi, verso il rapporto tra unità e unificazione, e il concetto di indivisibilità di uno Stato. Si ha unificazione quando, in maniera militare o in maniera consensuale, più territori diventano parte di una stessa unità statale o leggi di stati diversi vengono unificate. Che in Italia sia accaduto questo è indubitabile, sostiene Rotelli. Il concetto di unità implica un discorso più complesso. L’Italia, in Costituzione, è descritta come «una Repubblica democratica fondata sul lavoro», che è «una e indivisibile». Questa definizione si limita a rendere costituzionalmente inammissibili situazioni come la divisione della Cecoslovacchia, ma certo non preclude forme di federalismo, che, anzi, possono essere considerate auspicabili, guardando al combinato disposto degli articoli 5 e 114 della Carta costituzionale. Se il primo, infatti, enuncia che «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento»; il secondo sancisce, come citato in apertura, che la Repubblica è costituita da diversi organi di governo territoriale. In questo quadro, lo Stato è certamente elemento costitutivo, ma non l’unico e non sovraordinato rispetto agli altri.
Importante è, infine, l’auspicio di ordine metodologico che Ettore Rotelli rivolge all’uditorio. Ogni essere umano che sia esistito, e che abbia quindi adottato un comportamento o abbia determinato un comportamento, è storia. Tuttavia, in particolare nel ricercare analogie fra situazioni attuali e precedenti, nell’indagare i legami fra partiti odierni e del passato, occorre sempre tenere a mente che è opportuno evitare di giudicare un fatto storico in base a quanto accaduto dopo. Azioni e avvenimenti posteriori non possono essere criterio di giudizio su episodi precedenti. La storia è tutto quello che è avvenuto e che stato raccontato. Anche la storiografia è, infatti, ovviamente un fatto storico. Se, come tale, non potrà mai esistere una affermazione storiografica perfettamente esatta, perché ognuna è espressione di un punto di vista, chi scrive storia deve sempre cercare la verità.
Federico Sagramoso