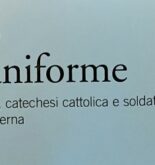In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, Luca Baldissara, professore di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Bologna, ha recentemente pubblicato per il Mulino una riflessione sulla festa civile del 25 aprile che si colloca nella medesimo campo d’indagine di altre sue pubblicazioni con il Mulino, come dimostra l’uscita nel 2023 Italia 1943. La guerra continua.
Baldissara si propone di compiere un’analisi per riscoprire il senso politico e civile della festa della Liberazione. A tal fine il saggio risulta tripartito.
Nella prima parte considera quanto avvenuto nei «vari» 25 aprile. Si ricorda pertanto come Liberazione non fosse avvenuta in un unico momento, ma in diverse fasi, seguite dalla deliberazione del CNLAI del 19 aprile e l’emanazione delle direttive del 21. Se la prima città a insorgere fu Bologna (il 21), l’ultima fu Udine (il 1° maggio), mentre le truppe tedesche che presidiavano lo Stelvio si arresero il giorno successivo. Il 25 aprile, dunque, dimostrava di essere una festa simbolica che raggruppava la liberazione delle varie città d’Italia e di riunificazione degli italiani a seguito della separazione decretata dallo sbarco in Sicilia del 9 luglio 1943. La disamina di Baldissara però si spinge oltre. Dimostra come la violenza repressiva nazifascista nell’ambito civile e militare durante l’«estate partigiana» (p.31), del 1944, che al contempo si traduceva in guerra civile, ritornasse nell’aprile del 1945, con il culmine della proclamazione dello stato d’assedio da parte del CNLAI (quindi l’assunzione dei poteri civili e militari), aprendo anche ma non solo «varchi alla fuoriuscita dell’odio accumulato nel tempo» (p.37). All’analisi dei tanti 25 aprile italiani, segue l’inizio della parte più importante del libro, ossia la seconda, che ripercorre il contesto delle celebrazioni nel dopoguerra a partire dal 1946 e dall’apertura della campagna per la Costituente.
Questa sezione prende pertanto in considerazione «il 25 aprile nel lungo dopoguerra» (p.53), proponendo alcune osservazioni sulle celebrazioni dei diversi decennali. Se negli anni del centrismo Mario Scelba e i provvedimenti da lui emanati portarono a un misurato festeggiamento, con una «disattenzione controllata» (p.69) e una distinzione fra celebrazione istituzionale e festa popolare destinata a durare fino ad oggi, l’apertura del governo al centro sinistra porta a far sentire, col tempo, la Resistenza come fattore fondatore della Repubblica. Non solo questo si avverte nella critica all’esperienza del governo Tambroni e all’apertura del MSI, ma anche nell’estensione del significato dell’antifascismo da lotta in ambito di occupazione e guerriglia a «modo di vita» (p.82) delle proteste degli anni Sessanta, fino a una sua interpretazione di classe nei successivi anni Settanta e l’esperienza del terrorismo.
Nella terza parte e ultima parte, la più consistente dal punto di vista delle pagine, l’autore indaga gli ultimi quarant’anni. Qui, Baldissara prende le mosse considerando le posizioni del PCI di fronte al terrorismo a partire dal 1976 e ricorda come l’antifascismo fosse considerato ciò da cui scaturì la democrazia, che bisognava proteggere da ogni forma del terrorismo, compreso quello «rosso» al suo culmine con il rapimento di Moro del 1978. Con l’arrivo al governo del PSI, le riflessioni sul 25 aprile, come quelle di Ruggero Orfei e di Corrado Bonfantini, si basavano sull’ «individualizzazione […] dell’origine dell’autonomismo socialista nella gabbia bipolare del sistema politico italiano e internazionale» (p.118), mentre l’antifascismo perdeva il carattere coesivo fra i partiti che fino a quel momento aveva mantenuto. Il fenomeno si accentuò con la crisi politica degli anni Novanta, che da una parte si palesò come una volontà di pacificazione degli italiani nel superamento della diade fascismo e antifascismo (come vorrebbe il discorso del 1996 del presidente della Camera Luciano Violante), dall’altra si manifestò in qualità di bisogno di innalzare la resistenza e l’antifascismo a «religione civile» (p.149) per comporre un’immagine di un’Italia del 1943-1945 in cui fosse possibile rispecchiarsi. Gli anni Duemila hanno visto invece l’uso del 25 aprile come una festa prima delegittimante della forza politica avversaria, poi oggetto di un discorso di banalizzazione, in cui si evita di affrontare il fenomeno complesso della Resistenza, giungendo all’attuale bipolarismo fra coloro che considerano l’antifascismo prodromo e base fondante del vivere democratico e dall’altra «una scolorita resistenza […] intesa (…) come espressione di una “scelta di popolo” e di “amor di patria”» (p.161).
Baldissara conclude quindi che rendere edotti i lettori sulle ragioni e il trascorso storico della festa potrebbe togliere il 25 aprile dai continui processi di manipolazione alle esigenze del presente. Si tratta di una riflessione opportuna, che invita a interrogarsi anche sulle modalità che segneranno l’80° anniversario della Liberazione.
Flavio Luigi Fortese