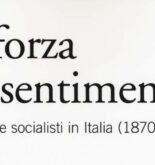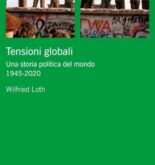È stato pubblicato per la collana Voci de il Mulino un importante saggio storiografico sulla condizione della storia nel tempo presente.
Benigno si interroga su quale sia il regime di storicità del nostro tempo, ovvero di quale concezione del passato il presente si nutra. Per arrivare a trovare una risposta l’autore analizza alcune delle idee portanti della modernità che oggi sono venute meno (l’idea di progresso e democrazia, le tensioni politiche scaturite durante e dopo il Sessantotto, la netta distinzione tra società politica e civile): segnala così che siamo alla prese con una nuova profonda crisi, differente da quella degli anni Trenta del Novecento, durante i quali l’ascesa del nazifascismo aveva fatto sfumare la concezione di continuità del percorso storico. Oggi il passato non è più visto come una concatenazione di eventi disposti verso il futuro, ma è «divenuto gradualmente un universo di mondi possibili sui quali sono spirati dei venti contrastanti, differenti temperie e anche qualche tempesta: mondi non disposti gerarchicamente od orientati unilateralmente a dar conto del nostro, ma invece dotati di riserve di senso che attendono domande innovative per essere esplorati» (p. 39). Alla base di questo cambiamento vi è la totale eclissi del fenomeno delle rivoluzioni come eventi periodizzanti e sostenitori di un nuovo ordine politico e morale. Nella parte del saggio in cui questo tema è trattato l’autore si concentra sia sul mutamento del concetto di rivoluzione prima e dopo la Rivoluzione francese, sia sulla caduta del comunismo e dell’URSS, in quanto eventi che hanno appannato l’idea di rivoluzione: «Poi, sul finire del XX secolo, col fallimento conclamato dell’esperienza comunista sovietica e con l’esaurirsi del socialismo come linguaggio politico della decolonizzazione, l’idea di rivoluzione è venuta appannandosi. Trionfava così un uso universale e per certi aspetti banalizzato del termine, volto a indicare non solo tutti i sommovimenti e i cambi di regime ma anche il mutamento impersonale prodotto dalla diffusione dell’innovazione tecnologica (la cosiddetta “rivoluzione digitale”); si esauriva perciò la sua percezione come passaggio politico imprescindibile per la vittoria del moderno sulle pastoie costipanti dell’arretratezza […] La rivoluzione, così, finiva per eclissarsi, e ciò sia nelle percezione corrente sia nella pratica storiografica.» (pp. 52-53).
Il punto cruciale della riflessione sta nell’indicare ciò che ha preso il posto della rivoluzione e le sue conseguenze. L’Olocausto, portando in evidenza la «centralità storica della vittima», ha creato l’idea che esista un «male assoluto» che assale il nostro tempo e ha conferito alla testimonianza della vittima una centralità nel discorso pubblico: «l’Olocausto/Shoah non si limita perciò a porsi come l’evento fondativo del racconto memoriale, ma, proprio come accadeva con la Rivoluzione francese al tempo del moderno, esso appare come una struttura normativa, che dona o forse è meglio dire ri-dona senso (un altro senso) all’interno del corso della storia. Se Auschwitz ha mutato le condizioni di pensabilità della storia, lo ha fatto in modo strutturale, spostando l’attenzione su una comunanza di destino che diventa l’unica modalità di compressione del passato» (p. 70). Ciò ha finito per imporre «la presenza nuova e ingombrante di una sorella o forse sorellastra della storia, la memoria storica» (p. 62). Essa si avvale di una superiorità mediatica rispetto alla storia, capace di produrre una narrazione coinvolgente che ritrova il suo «punto di attacco, originale e mitico» (p. 67) nel trauma, assumendo un aspetto sacrale, che ha la pretesa di dare un senso «all’intera storia» (p. 75).
Alle conseguenze sull’influenza che tutto ciò ha avuto sul mestiere dello storico sono dedicati gli ultimi capitoli del saggio. Le fonti oggi non sono più dei mezzi che permettono di vedere chiaramente il passato, ma non sono nemmeno dei riflessi di ciò che si chiede loro. Sono diventate un «perimetro» (p. 87) in cui si esprime ciò che resta in seguito a un processo di esclusione, ciò che è deontologicamente affermabile: «Lo storico ha infatti il diritto di proporre un’interpretazione unicamente nel rispetto del dicibile, e questo dicibile è, su un piano deontologico, solo quello che le fonti consentono di affermare. Non un binario, quindi, ma un perimetro. Quella che resta da un processo di esclusione. Questa modalità distingue il mestiere dello storico da quello del romanziere, del pittore e del poeta e lo avvicina alle pratiche consolidate di tutte le discipline scientifiche sociali come l’antropologia, la sociologia e in parte la psicologia. Vale a dire quelle discipline che, come la storia, non possono permettersi, come le discipline scientifiche “dure”, di delimitare le proprie catene di preposizioni euristiche entro uno spazio logico chiuso e impermeabile al linguaggio naturale.» (p. 87). Il ruolo dello storico è fortemente condizionato dalla metodologia di lavoro e in un tempo in cui tutti sono liberi di esprimersi sugli eventi passati egli deve affermare ciò che sul passato si può o non si può dire.
L’ultimo sguardo allo stato odierno di storicità è dedicato alle tendenze storiografiche.
Generalmente Benigno indica come mutamento sostanziale la prospettiva di lunga durata, che ha permesso alla storia di collegarsi con nuove discipline, come la biologia, inaugurando così quella che l’autore chiama «Deep History». A questa affianca anche le tendenze della World History, ovvero il porre attenzioni alle diversità ambientali, culturali e sociali, e della Global History, quindi il tentativo di ricostruire i collegamenti e gli scambi fra persone e culture. Fondamentale è poi l’importanza che l’autore attribuisce alla soggettività degli storici, che hanno perso la tendenza a nascondere la propria dimensione personale «È venuto emergendo l’abbandono della vecchia tendenza a nascondere la dimensione personale e soggettiva degli storici, sottolineando una prepotente retroversione degli scrittori di storia verso la propria soggettività e in breve una sorta di ritorno alla “tirannide dell’io”» (p. 130). Benigno ricollega questo mutamento all’incapacità di cogliere i nessi causali degli eventi e quindi al conseguente ripiegamento verso le scelte individuali e alle emozioni, come dimostrerebbe lo sviluppo sempre più avanzato del filone storiografico dell’Emotional History. A tutto ciò si aggiunga oggi la tendenza a preferire tematiche quali la nazione, l’etnia e il genere, indagate, però, solamente da chi idealmente appartiene al genere, all’etnia o alla nazione su cui indaga. Ovviamente la memoria storica è facilmente avvantaggiata da questo fenomeno, ma nel contempo si genera anche un «populismo storiografico, vale a dire il racconto storico di ispirazione nazionalista che disegna un popolo da unificare e rende coeso (mentre quello che produce sono in realtà divisioni), è volto a selezionare i temi della memoria pubblica, allontanando o smorzando quelli scomodi» (pp. 153-154).
Il saggio di Benigno rappresenta oggi un complesso nodo cruciale per comprendere il panorama storiografico italiano e la sua evoluzione in merito al ruolo della storia nel nostro presente. La prosa piacevole, diretta, coinvolgente rende i fini ragionamenti dell’autore fruibili non solo ai colleghi storici ma anche al grande pubblico.
Flavio Luigi Fortese